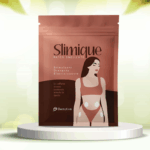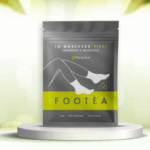Ogni giorno, l’aria che respiri è un cocktail invisibile di sostanze che derivano da traffico, riscaldamento domestico, attività industriali e processi naturali. I principali inquinanti atmosferici che popolano la tua città comprendono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NO2), l’ozono (O3), gli ossidi di zolfo (SOx), l’ammoniaca (NH3), il monossido di carbonio (CO), il benzene e altri composti organici volatili. In alcune città si trovano anche tracce di metalli pesanti come arsenico, cadmio e nichel, che sono generalmente legati alle emissioni industriali.inquinanti atmosferici.
La composizione dell’aria nelle città italiane
Il particolato atmosferico, conosciuto come PM10 e PM2.5, rappresenta una delle minacce più rilevanti per la salute pubblica perché arriva fino agli alveoli polmonari provocando infiammazioni e contribuendo all’insorgere di malattie respiratorie e cardiovascolari. Il PM10 è formato sia da emissioni dirette (polveri derivanti da traffico, erosione di pneumatici e freni, combustione) sia da reazioni chimiche nell’atmosfera, nelle quali sono coinvolti precursori come l’ammoniaca proveniente da fertilizzanti e allevamenti.
Gli ossidi di azoto, con il NO2 in primo piano, vengono prodotti principalmente dalla combustione nei motori delle auto e nell’industria: queste sostanze, oltre a essere irritanti per le vie respiratorie, contribuiscono anche alla formazione di particolato secondario e ozono troposferico. L’O3, non emesso direttamente ma generato da reazioni chimiche tra ossidi di azoto e composti organici volatili sotto l’effetto della luce solare, provoca danni ad apparato respiratorio e sistema cardiovascolare. Gli ossidi di zolfo (SOx), pur in diminuzione grazie alle politiche di metanizzazione, persistono laddove si utilizzano ancora combustibili solidi e liquidi (come il gasolio).
Quanto sei davvero esposto agli inquinanti?
Nei centri urbani, la presenza di questi inquinanti è costante durante tutto l’anno e le rilevazioni recenti dipinte dalle agenzie ambientali mostrano una realtà preoccupante. Nel 2024, il 96% della popolazione urbana era esposta a livelli di PM2.5 sopra il limite raccomandato, il 94% era a rischio per ozono e l’88% per biossido di azoto.
Il problema del PM10 è particolarmente acuto: in molte città italiane vengono oltrepassate le soglie nazionali ed europee che impongono un limite massimo di 35 giorni annui con concentrazioni superiori a 50 µg/m³. A Frosinone-Scalo, Milano, Verona e altre città, le centraline hanno registrato oltre 60 giorni di superamento, con punte di 70 giorni nei casi peggiori.
Per il NO2, benché la media annuale non abbia ancora oltrepassato il limite europeo di 40 µg/m³, numerosi capoluoghi sono sulla soglia: Napoli e Palermo toccano periodicamente il limite, mentre Milano, Como, Catania, Torino e Roma presentano valori vicini con medie tra 30 e 33 µg/m³. Secondo le stime attuali, buona parte delle città dovrà ridurre le concentrazioni tra il 20% e il 39% per rientrare nei limiti più restrittivi previsti dal 2030, e alcune località saranno costrette a dimezzare le proprie emissioni.
- Le polveri sottili PM2.5 sono le più insidiose perché penetrano in profondità nei polmoni.
- Il NO2 è legato quasi esclusivamente al traffico veicolare urbano e quindi risulta più elevato nei quartieri trafficati.
- L’ozono tende a crescere nei mesi estivi raggiungendo valori critici soprattutto durante le ondate di calore.
- Arsenico, cadmio e nichel sono presenti vicino a siti industriali e rappresentano un rischio aggiuntivo per chi risiede in quelle aree.
I limiti e le carenze nel controllo della qualità dell’aria
La misurazione degli inquinanti atmosferici nelle città italiane si affida principalmente a una rete di centraline di monitoraggio, generalmente gestite dalle agenzie regionali per la protezione ambientale. Queste centraline, tuttavia, soffrono di alcune criticità strutturali.
Distribuzione insufficiente
Le centraline sono collocate spesso nei punti più trafficati, ma la loro densità e copertura non è omogenea: molte zone periferiche, aree industriali o residenziali rimangono sottorappresentate nei monitoraggi.
Soglie e limiti datati
I limiti di legge sono fissati in base alle direttive europee, che però spesso recepiscono le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità con ritardo. Ad esempio, il limite per il PM2.5 stabilito dalla normativa europea è 25 µg/m³ come media annuale, mentre l’OMS suggerisce non più di 5 µg/m³ per minimizzare i rischi sanitari. La situazione è simile per PM10 e NO2, dove i limiti sono più elevati rispetto alle raccomandazioni OMS, portando molte città a rispettare la legge ma a non garantire la tutela della salute.
Misure mancanti e dati parziali
In alcune città le centraline non coprono tutte le tipologie di inquinanti; mancano spesso dati su composti organici volatili non metanici, microinquinanti, metalli pesanti e IPA (idrocarburi policiclici aromatici). Questa mancanza impedisce di tracciare un quadro completo dei rischi, lasciando intere popolazioni esposte senza che le autorità ne siano pienamente consapevoli.
Monitoraggio discontinuo
Le centraline possono subire periodi di mancato funzionamento, manutenzione inadeguata o ritardi nell’aggiornamento dei dati; questo fa sì che spesso l’informazione fornita sia parziale e non tempestiva, specie durante episodi acuti di smog.
L’aria che inquini: come la tua vita quotidiana contribuisce
Gran parte dell’inquinamento urbano è il frutto delle attività quotidiane di milioni di persone:
- Utilizzo dell’auto privata per brevi spostamenti, specialmente nei centri città, è il primo responsabile di NO2 e PM10, con impatti diretti anche sui livelli di ozono.
- Riscaldamento domestico con combustibili fossili (pellet, gasolio, legna, metano) genera fumi e polveri, contribuendo sia alle emissioni dirette, sia ai precursori per la formazione di particolato secondario.
- Attività agricole: la volatilizzazione di ammoniaca da fertilizzanti e allevamenti intensivi contribuisce significativamente alla formazione di PM10 secondario.
- Processi industriali: emissioni di metalli pesanti, benzene e altri composti organici, spesso localizzate ma talvolta capaci di estendersi anche in zone residenziali.
Proprio queste emissioni quotidiane, che sembrano inoffensive nel singolo gesto, si sommano fino a creare una nube persistente nei cieli urbani. Le condizioni meteorologiche accentuano il problema, soprattutto in inverno quando la bassa ventilazione impedisce il ricambio d’aria e contribuisce a mantenere alta la concentrazione di inquinanti.
Secondo i report annuali, se non saranno introdotte misure incisive e drastiche, tra cui la riduzione del traffico urbano, il potenziamento del trasporto pubblico e il passaggio a fonti energetiche pulite, il 71% delle città si troverà fuorilegge rispetto ai nuovi limiti su PM10 già dal 2030.
L’esposizione quotidiana a questi inquinanti non è quindi un rischio astratto ma una realtà che incide su aspettativa di vita, incidenza di patologie respiratorie, cardiovascolari e tumorali: secondo l’OMS, l’aria delle città italiane continua a rappresentare una minaccia silenziosa e sottovalutata.particolato atmosferico.